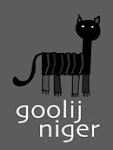Ieri mattina sono andato alla presentazione del progetto formativo della scuola primaria dove dovrei iscrivere mio figlio Cecio. In quella stessa scuola Gabo sta frequentando la quarta elementare.
Dell'ora di incontro, viene dedicato quasi tutto il tempo a parlare di numero di ore complessive, 27, 30, 40... di come tali ore vengono ripartire tra le materie, e come questo e come quello. Insomma, una lunga lista di casistiche organizzative che hanno la loro importanza ma che trovo complessivamente marginali.
Ho fatto il rappresentante di classe per i primi tre anni di elementare di Gabo. Ho parlato con le insegnanti, con gli altri genitori, ecc. e ho capito molte cose della scola pubblica. Soprattutto cosa non si può fare. Colpa del Dirigente Scolastico, si diceva allora. Il Dirigente Scolastico è rigido. E così via. Una parte della verità.
L'incontro di ieri era per me particolarmente significativo perché era presente il nuovo Dirigente Scolastico, in carico da settembre del 2015. Avevo delle aspettative. Ero interessato a capire.
Ho posto quattro domande:
- L'insegnamento della lingua inglese è totalmente inadeguato, per limiti oggettivi di metodo dell'insegnante. Cosa avete intenzione di fare?
- L'insegnamento delle arti e in particolare della musica è quasi totalmente assente. L'insegnante che dovrebbe trasmettere le prime conoscenze musicali ai nostri bambini è quella di matematica e ... di musica non sa nulla. Non ha mai suonato, non ha mai studiato la materia. Per sua stessa ammissione è in grande imbarazzo nel trattare la materia. Questo perché la riforma di alcuni anni fa ha attribuito la musica agli insegnanti di matematica senza valutare se questi fossero in grado di trattarla. Come avete intenzione di agire?
- Ritengo che le prove invalsi siano una perdita di tempo per i nostri bambini. Si insegna loro un metodo per rispondere velocemente a dei quiz, senza che questo abbia alcun significato per le reali necessità di apprendimento dei bambini tra i 6 e gli 11 anni. C'è una riflessione in atto su questo tema?
- Avete parlato a lungo degli aspetti organizzativi della scuola, ma non ci avete trasmesso in nessun modo l'idea di bambino e di educazione che avete intenzione di sviluppare con la vostra didattica. Come mai?
In estrema sintesi le risposte del Dirigente sono state le seguenti:
- L'idea di educazione è definita dal Ministero. Noi ci atteniamo a questa.
- E' stato previsto un fondo per l'aggiornamento delle insegnanti, che si formeranno dove hanno carenze.
- Le invalsi hanno tante problematiche, ma sono l'unico metodo oggettivo per valutare i livelli delle scuole. Lo sapete che le scuole che per lo più non fanno le prove invalsi sono quelle del sud? Provate a chiedervi perché.
- Le faccio io una domanda. Perché ha iscritto il suo primo figlio a questa scuola quattro anni fa?
Io sono demoralizzato. Per la mancanza di progettualità, per la sterilità delle risposte, per la totale mancanza di attenzione per le esigenze reali dei nostri figli oggi. E per quel delicato attacco rivoltomi con l'ultima domanda.
Con un po' di tempo mi piacerebbe tornare su queste risposte del Dirigente Scolastico. Ci tengo a dire che dalle sue risposte non emergono reali progetti di investimento per i nostri figli, che i problemi appaiono del tutto sottovalutati, e analizzati esclusivamente da un punto di vista burocratico.
Un esempio. Il Dirigente parla di fondi per l'aggiornamento delle insegnanti sui temi in cui si sentono carenti. Chi decide su cosa aggiornarsi? Le insegnanti. Esiste un progetto formativo per le insegnanti di matematica sull'insegnamento della musica? Al momento, come mi ha confermato l'insegnante di matematica di Gabo, per questo plesso no. Quindi il problema della musica rimarrà tale per ... quanto tempo?
Questo è quanto. Da qui si parte.
Probabilmente Cecio andrà in un'altra scuola.
E tutto questo mi provoca grande tristezza.
Visualizzazione post con etichetta educazione. Mostra tutti i post
Visualizzazione post con etichetta educazione. Mostra tutti i post
domenica 17 gennaio 2016
mercoledì 18 settembre 2013
Fare i compiti
“Le ore da svegli che i miei figli
non passano a scuola sono poco
più di quattro”, scrive la
blogger Clare Wapole sull’Hufington
Post di Chicago. “Come
genitore, non riesco a insegnargli
mentre sono a casa tutto
quello che vorrei e quindi
sarò costretta a dargli dei compiti
da svolgere nelle sette ore
che passano in classe. Le mie
lezioni s’imparano meglio se
c’è continuità con il resto della
giornata, una buona connessione
genitore/insegnante e
tutte quelle storie là. Messaggio
per le maestre: i miei igli
verranno a scuola con un cesto
di panni puliti. Stiamo lavorando
sull’autosuicienza e su come
dividere, piegare e mettere
a posto i loro vestiti. Quello
che non riusciranno a inire
prima di andare a letto lo faranno
in classe. Porteranno la
teca di vetro delle lucertole.
Senza cure costanti, muoiono.
Mia iglia verrà con una tuta di
lycra e le parallele per esercitarsi
per il corso di ginnastica
artistica e mio iglio con la sua
isarmonica. Ma soprattutto
avranno gli zaini pieni di Barbie,
giochi, biciclette, igurine
del baseball, un preparato per
torte, un albero su cui arrampicarsi.
Gli sto insegnando che
esiste un tempo per imparare e
uno per giocare, che bisogna
staccare completamente per
essere pronti a imparare di
nuovo il giorno dopo. E quattro
ore bastano a malapena, soprattutto
se devono fare i compiti”.
da Internazionale 1017
non passano a scuola sono poco
più di quattro”, scrive la
blogger Clare Wapole sull’Hufington
Post di Chicago. “Come
genitore, non riesco a insegnargli
mentre sono a casa tutto
quello che vorrei e quindi
sarò costretta a dargli dei compiti
da svolgere nelle sette ore
che passano in classe. Le mie
lezioni s’imparano meglio se
c’è continuità con il resto della
giornata, una buona connessione
genitore/insegnante e
tutte quelle storie là. Messaggio
per le maestre: i miei igli
verranno a scuola con un cesto
di panni puliti. Stiamo lavorando
sull’autosuicienza e su come
dividere, piegare e mettere
a posto i loro vestiti. Quello
che non riusciranno a inire
prima di andare a letto lo faranno
in classe. Porteranno la
teca di vetro delle lucertole.
Senza cure costanti, muoiono.
Mia iglia verrà con una tuta di
lycra e le parallele per esercitarsi
per il corso di ginnastica
artistica e mio iglio con la sua
isarmonica. Ma soprattutto
avranno gli zaini pieni di Barbie,
giochi, biciclette, igurine
del baseball, un preparato per
torte, un albero su cui arrampicarsi.
Gli sto insegnando che
esiste un tempo per imparare e
uno per giocare, che bisogna
staccare completamente per
essere pronti a imparare di
nuovo il giorno dopo. E quattro
ore bastano a malapena, soprattutto
se devono fare i compiti”.
da Internazionale 1017
Etichette:
bambini,
crescere,
educazione,
internazionale,
scuola,
vita
venerdì 6 settembre 2013
Futuro interrotto
L’India è una potenza globale
emergente e cavalca l’onda del bonus demografico.
O almeno così piace credere
agli indiani. In realtà, la chiave del futuro
successo indiano – la grande quantità di
giovani – è una bomba a orologeria. È una
massa crescente di ragazzi per lo più denutriti,
poco istruiti, non idonei al lavoro, che
aspirano a una vita migliore ma non hanno
i mezzi per ottenerla. Perché? Perché non
sono qualiicati per il mercato del lavoro e,
anche se lo sono, l’impiego non c’è.
La forza lavoro indiana (la popolazione
tra i 15 e i 64 anni) è costituita da 430 milioni
di persone. Di queste, solo una minima
parte ha ricevuto una vera formazione professionale.
Il settore formale, dove si concentrano
le aspirazioni, il denaro e la crescita
economica, impiega solo 30 milioni di
persone. Questo signiica che gli altri 400
milioni si muovono nel settore informale,
cioè si arrangiano. Inoltre, il 60 per cento
della popolazione attiva è occupato nel settore
agricolo, che contribuisce al pil solo
per il 18 per cento. Secondo Amitabh Kundu,
che insegna economia dello sviluppo
all’Università Jawaharlal Nehru di New
Delhi, anche se nei prossimi vent’anni si
aggiungeranno altri 480 milioni di persone
alla forza lavoro già esistente, per trasformare
questo bonus demograico in un vantaggio
economico e sociale sarà essenziale
la formazione professionale. “I giovani sono
delusi dal sistema di governo e non perdono
occasione per dimostrarlo. I movi-
menti anticorruzione guidati da Baba Ramdev,
Anna Hazare e perino le proteste di
New Delhi contro gli stupri sono il rilesso
della loro frustrazione”, spiega Kundu.
“Questa insoddisfazione provoca instabilità
politica e il nostro vantaggio generazionale
potrebbe trasformarsi in un disastro”.
da Internazionale 1015, articolo di Avalok Langer tratto da Tehelka
emergente e cavalca l’onda del bonus demografico.
O almeno così piace credere
agli indiani. In realtà, la chiave del futuro
successo indiano – la grande quantità di
giovani – è una bomba a orologeria. È una
massa crescente di ragazzi per lo più denutriti,
poco istruiti, non idonei al lavoro, che
aspirano a una vita migliore ma non hanno
i mezzi per ottenerla. Perché? Perché non
sono qualiicati per il mercato del lavoro e,
anche se lo sono, l’impiego non c’è.
La forza lavoro indiana (la popolazione
tra i 15 e i 64 anni) è costituita da 430 milioni
di persone. Di queste, solo una minima
parte ha ricevuto una vera formazione professionale.
Il settore formale, dove si concentrano
le aspirazioni, il denaro e la crescita
economica, impiega solo 30 milioni di
persone. Questo signiica che gli altri 400
milioni si muovono nel settore informale,
cioè si arrangiano. Inoltre, il 60 per cento
della popolazione attiva è occupato nel settore
agricolo, che contribuisce al pil solo
per il 18 per cento. Secondo Amitabh Kundu,
che insegna economia dello sviluppo
all’Università Jawaharlal Nehru di New
Delhi, anche se nei prossimi vent’anni si
aggiungeranno altri 480 milioni di persone
alla forza lavoro già esistente, per trasformare
questo bonus demograico in un vantaggio
economico e sociale sarà essenziale
la formazione professionale. “I giovani sono
delusi dal sistema di governo e non perdono
occasione per dimostrarlo. I movi-
menti anticorruzione guidati da Baba Ramdev,
Anna Hazare e perino le proteste di
New Delhi contro gli stupri sono il rilesso
della loro frustrazione”, spiega Kundu.
“Questa insoddisfazione provoca instabilità
politica e il nostro vantaggio generazionale
potrebbe trasformarsi in un disastro”.
da Internazionale 1015, articolo di Avalok Langer tratto da Tehelka
Etichette:
articolo,
economia,
educazione,
giornalismo,
india,
internazionale
domenica 14 aprile 2013
giovedì 17 gennaio 2013
Giochiamo insieme?
quando ci sveglieremo
tutti insieme
e smetteremo di infliggere tutto questo dolore
ai nostri bambini?
quando torneremo tutti insieme
a giocare
sulla nostra pelle
per imparare cose nuove su di noi
e sul mondo?
tutti insieme
e smetteremo di infliggere tutto questo dolore
ai nostri bambini?
quando torneremo tutti insieme
a giocare
sulla nostra pelle
per imparare cose nuove su di noi
e sul mondo?
lunedì 4 giugno 2012
Come un bambino di cinque anni
La compassione si esercita prima di tutto all'interno della propria famiglia.
Queste pagine di Thich Nhat Hanh dal libro Discorsi ai bambini (ed. Ubaldini) sono per me di grande ispirazione e le condivido con gioia.
Queste pagine di Thich Nhat Hanh dal libro Discorsi ai bambini (ed. Ubaldini) sono per me di grande ispirazione e le condivido con gioia.
Etichette:
cambiamento,
compassione,
educazione,
meditazione,
thich nhat hanh
giovedì 23 febbraio 2012
Tecnica ed espressione
Imparare una tecnica può procurarci un lavoro, ma non ci rende creativi; mentre se c'è la gioia, se c'è il fuoco creativo, esso troverà il modo di esprimersi, senza bisogno di studiare un metodo espressivo. Chi vuole davvero scrivere una poesia la scrive e, se possiede la tecnica, tanto meglio; ma perché dare un'enfasi eccessiva a ciò che costituisce solo un mezzo di comunicazione se poi non si ha niente da dire? Quando c'è amore nel cuore, non abbiamo bisogno di cercare il modo di mettere insieme le parole. [...]
Per cantare dobbiamo avere un canto nel cuore, ma poiché l'abbiamo perso ci limitiamo a inseguire il cantante. Senza un intermediario ci sentiamo persi, ma dobbiamo perderci prima di poter scoprire qualsiasi cosa. La scoperta è l'inizio della creatività, e senza creatività, per quanto facciamo, non possono esserci né pace né felicità. [...]
La libertà di creare giunge con la conoscenza di sé, ma la conoscenza di sé non è un dono. Si può essere creativi anche se non si ha un talento particolare. La creatività è una condizione dell'essere in cui la mente non è tutta presa dalle esigenze e dalle attività del desiderio.
Jiddu Krishnamurti, Educare alla vita, ed. Mondadori
Per cantare dobbiamo avere un canto nel cuore, ma poiché l'abbiamo perso ci limitiamo a inseguire il cantante. Senza un intermediario ci sentiamo persi, ma dobbiamo perderci prima di poter scoprire qualsiasi cosa. La scoperta è l'inizio della creatività, e senza creatività, per quanto facciamo, non possono esserci né pace né felicità. [...]
La libertà di creare giunge con la conoscenza di sé, ma la conoscenza di sé non è un dono. Si può essere creativi anche se non si ha un talento particolare. La creatività è una condizione dell'essere in cui la mente non è tutta presa dalle esigenze e dalle attività del desiderio.
Jiddu Krishnamurti, Educare alla vita, ed. Mondadori
Etichette:
educazione,
jiddu krishnamurti,
libertà di espressione
lunedì 20 febbraio 2012
Educare alla vita
untitled, di akab
Proseguono le riflessioni sull'educazione e la scuola.
Oggi riporto alcuni passi di Jiddu Krishnamurti, tratti dal piccolo ma fondamentale testo Educare alla vita, ed. Mondadori (i grassetti nel testo sono miei).
Quando siamo giovani, molto spesso la famiglia e la scuola instillano in noi la paura. Né i genitori né gli insegnanti hanno la pazienza, il tempo o la saggezza di dissipare le paure istintive della fanciullezza che, a mano a mano che cresciamo, dominano i nostri atteggiamenti e giudizi creando numerosissimi problemi. Il giusto tipo di educazione deve prendere in considerazione il problema della paura, perché essa distorce completamente la nostra visione della vita. Essere privi di paura è l'inizio della saggezza, e solo la giusta educazione può determinare quella libertà dalla paura in cui fiorisce l'intelligenza più profonda e creativa.
Premio e punizione per i nostri atti non fanno che rinforzare l'egocentrismo. Agire per amore di qualcuno, in nome della patria o di Dio, conduce alla paura, e questa non può costituire la base di un'azione giusta. Se vogliamo aiutare un bambino a essere premuroso con gli altri, non dobbiamo cercare di comprarlo con l'amore, ma avere il tempo e la pazienza per spiegargli cosa vuol dire essere premurosi.
Non esiste il vero rispetto per l'altro se ci si aspetta un premio, perché la ricompensa o la punizione diventano più importanti del sentimento di rispetto. Se non rispettiamo il bambino, ma ci limitiamo a offrirgli un rinforzo positivo o negativo, non facciamo che incoraggiare l'avidità e la paura. Poiché anche noi siamo stati abituati ad agire in vista di un risultato, non capiamo come possa esistere un'azione libera dal desiderio del profitto.
Il giusto tipo di educazione incoraggerà la sollecitudine e la considerazione per gli altri senza allettamenti o minacce di alcun tipo. Se smettiamo di cercare dei risultati immediati, cominceremo a capire quanto sia importante che entrambi, l'educatore e il bambino, siano liberi dalla paura della punizione o dalla speranza del premio come da ogni altra forma di coercizione; ma finché l'autorità entrerà nella relazione, continuerà a esistere la coercizione.[...]
L'esistenza non sussiste senza relazione, e senza la conoscenza di sé qualsiasi relazione, con una sola persona o con molte, genera conflitto e dolore. Certo, è impossibile spiegarlo completamente a un bambino; ma se l'educatore e i genitori afferrano nel profondo il pieno significato della relazione, allora con l'atteggiamento, il comportamento e il modo di parlare saranno sicuramente in grado di trasmettere al bambino il senso di una vita spirituale, senza troppi discorsi o spiegazioni.[...]
La giovinezza è il periodo in cui crescere aperti e limpidi, e se noi adulti abbiamo la capacità di comprendere, possiamo aiutare i giovani a liberarsi dagli ostacoli cha la società ha loro imposto, o da quelli che essi stessi proiettano. Se la mente e il cuore del bambino non sono plasmati da preconcetti e pregiudizi religiosi, egli sarà libero di scoprire attraverso la conoscenza di sé ciò che è al di sopra di lui e che va oltre.
La vera religiosità non è un insieme di credenze e di rituali, di speranze e paure; se permettiamo al bambino di crescere senza l'ostacolo di queste influenze, allora forse, una volta maturo, comincerà a indagare la natura della realtà e di Dio. Per questo, quando si educa un bambino, sono necessari comprensione e un profondo insight.
mercoledì 15 febbraio 2012
Il potere disciplinare e la scuola
compagni, di akab
Ecco come Foucault descrive il potere disciplinare, soffermandosi, in un passaggio, sulla disciplina scolastica:
Primo, il potere disciplinare esercita una pressione continua che verte non tanto sull’errore, sulla colpa o sul danno, bensì sulla potenzialità del comportamento. Ancor prima che il gesto sia compiuto, deve essere possibile identificare qualcosa, e il potere disciplinare deve intervenire, ma intervenire in un certo senso prima della stessa manifestazione del comportamento, prima del corpo, del gesto o del discorso, a livello di virtualità, della disposizione, della volontà, a livello di quello che potremmo chiamare l’anima. [...]
Secondo, il potere disciplinare ha un carattere panottico: vedere tutto, ininterrottamente, tutti quanti. Esige l’organizzazione di una polarità genetica del tempo; esige che si proceda, inoltre, a un’individualizzazione centralizzata che ha come supporto e come strumento la scrittura; implica, infine, un’azione punitiva e continua sulle virtualità del comportamento che proietta così, dietro il corpo in quanto tale, quella che potremmo chiamare una psiche.
Terzo, il potere disciplinare è isotopico, o per lo meno tende all’isotopia. Ogni elemento di un dispositivo disciplinare occupa un posto ben determinato: è subordinato ad alcuni elementi, e a sua volta ne subordina a sé altri. […] Ma isotopia vuol dire, soprattutto,un’altra cosa, e cioè il fatto che, nel sistema disciplinare, il principio di distribuzione e classificazione di tutti gli elementi implica necessariamente qualcosa come un residuo, e dunque che c’è sempre qualcosa che potremmo definire come l’ “inclassificabile”. […] A fare da ostacolo [ai dispositivi disciplinari] sarà il residuo, l’irriducibile, l’inclassificabile, l’inassimilabile.
[…] È a partire dal momento in cui si impone la disciplina scolastica che vediamo apparire qualcosa come il debole di mente. È solo in rapporto a questa disciplina che potrà esistere un soggetto a essa irriducibile. Colui che non impara a leggere e a scrivere, infatti, comincerà a emergere come un problema, un limite, solo a partire dal momento in cui la scuola segue uno schema disciplinare. […]
In breve, il potere disciplinare presenta questa duplice proprietà di essere anomizzante, vale a dire di ridurre costantemente ai margini un certo numero di individui, di produrre anomia, di far emergere dell’irriducibilità, e al contempo di essere sempre normalizzatore, di inventare sempre nuovi sistemi di recupero, di ristabilire ogni volta, di nuovo, la regola. A caratterizzare il potere disciplinare, insomma, è un perpetuo lavoro della norma all’interno dell’anomia. […] Potremmo dire che il potere disciplinare ha come proprietà senza dubbio fondamentale quella di fabbricare corpi assoggettati e di applicare appunto la funzione-soggetto al corpo. Esso fabbrica, distribuisce, corpi assoggettati. È individualizzante, [ma solo nel senso che] l’individuo [non] è altro che il corpo assoggettato […], imprigionato all’interno di un sistema di sorveglianza e sottomesso a una serie di procedure di normalizzazione.
La scuola degli animali
anguilla, disegno di akab
A queste obiezioni, ho risposto nel tempo maturando la convinzione che sviluppare e assecondare le proprie inclinazioni non potesse in alcun modo essere un difetto. A maggior ragione se a pretendere omogeneità di comportamenti erano insegnani privi di interesse e passione per il loro lavoro e per il compito alto, importantissimo che avevano. Una convinzione che, al tempo, sembrava più cocciutaggine, e che mi costò per tutti e cinque gli anni di scuole superiori l'8 in condotta.
Ricordo anche che, dopo il diploma, ero uno dei pochi tra i miei compagni che aveva sviluppato un'idea chiara su cosa avrebbe voluto fare successivamente. Non importa poi, se tale idea sarebbe mutata, cambiata radicalmente nel corso degli anni. Queste metamorfosi sono parte della vita.
Ma che scuola è quella che ti costringe a scappare dalla tua vocazione, dalle tue inclinazioni, che non stimola la tua intelligenza emotiva, che non ti permette di sviluppare un rapporto critico e riflessivo con la realtà che ci circonda? Dove, anzi, il pensiero critico è visto come un ostacolo alla realizzazione delle lezioni, di un programma rigido prestabilito?
Una storia che prendo in prestito da un libro di Osho (I libri del Fiore d'Oro, che è una miniera di spunti) ce lo spiega con una bellissima metafora.
La scuola degli animali
Un giorno, gli animali si radunarono nella foresta e decisero di aprire una scuola. Erano presenti un coniglio, un uccello, uno scoiattolo, un pesce e un'anguilla, che formarono una Commissione Direttiva. Il coniglio proclamava che la corsa doveva essere inclusa nel programma, l'uccello insisteva che il volo doveva esservi incluso, il pesce proclamava che il nuoto doveva essere incluso nel programma, lo scoiattolo proclamava che l'arrampicamento sugli alberi doveva esservi assolutamente incluso. Riunirono tutte queste richieste e scrissero una guida al corso di studi. In seguito insistettero sulla necessità che tutti gli animali seguissero tutti i programmi.
Il coniglio, sebbene avesse guadagnato una "A" nella corsa, scoprì che l'arrampicamento sugli alberi era un problema: fece una caduta rovinosa che gli procurò un danno cerebrale e non poté più correre. Scoprì dunque che, invece di guadagnare una "A" nella corsa, otteneva solo una "C", e naturalmente, nell'arrampicamento sugli alberi, avrebbe guadagnato solo una "F".
L'uccello nel volo aveva dato un bellissimo spettacolo, ma quando dovette scavare una tana nel terreno non fece una figura altrettanto bella: si ruppe il becco e le ali. Ben presto si trovò a guadagnare una "C" nel volo, una "F" nello scavare una tana nel terreno e fece una fatica infernale nell'arrampicamento sugli alberi.
La morale della storia fu che un'anguilla mentalmente ritardata risultò la prima della classe: aveva fatto ogni cosa a metà, ma gli insegnanti erano tutti felici perché tutti gli animali avevano seguito tutti i programmi e definirono il loro corso un' "istruzione su ampie basi".
Osho conclude la storia così: Tutto ciò fa ridere, ma è esattamente così che voi avete fatto. Stiamo davvero tentando di rendere ogni essere umano uguale a tutti gli altri, di conseguenza distruggiamo in ciascuno il potenziale di essere se stesso.
Etichette:
educazione,
libertà di espressione,
osho,
scuola,
vita
Iscriviti a:
Post (Atom)
Tutti i testi e le immagini di questo blog sono (c) di
Guglielmo Nigro, salvo dove diversamente indicato.
Guglielmo Nigro, salvo dove diversamente indicato.
Puoi diffonderli a tuo piacere ma ti chiedo di
esplicitare sempre l'autore e/o la fonte.
esplicitare sempre l'autore e/o la fonte.